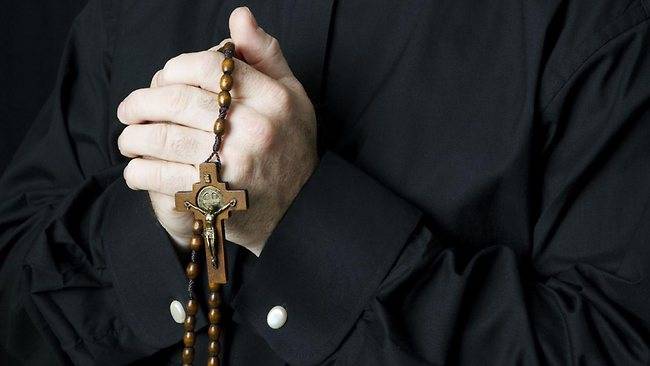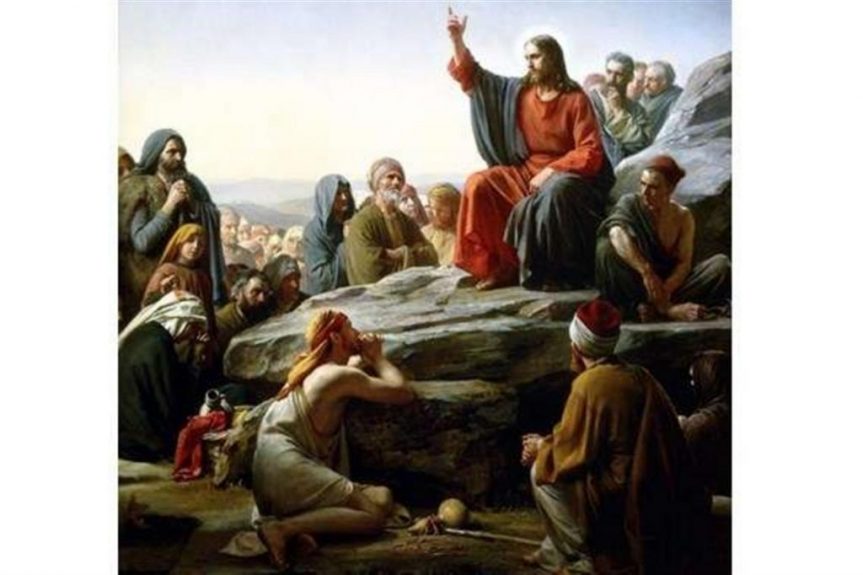Autore: Giovanni Mario Tirante
Il prete: un ministero che cambia
– Prof. Unterburger, in che cosa differisce l’immagine del prete nel XIX secolo da quella che conosciamo oggi?
A partire dal Medioevo, è diventato sempre più importante che i preti siano dei buoni pastori. L’ideale del buon pastore era molto importante, e ha sostituto ciò che prima era decisivo, ossia offrire con mani pure il culto, il rito, il sacrificio eucaristico. Questi aspetti non sono scomparsi, ma la dimensione pastorale è divenuta sempre più importante.
Nel secolo 19° si aggiunsero molte altre aspetti. Da una parte, il fatto di una società ostile alla Chiesa, da cui prendere le distanze. Dall’altra, una riforma della formazione in modo da garantire ai preti di essere formati accademicamente e di rispondere a determinati standard accademici.
Ne derivò che i preti furono tenuti in grande considerazione, soprattutto, naturalmente, dai loro fedeli, ma spesso anche al di fuori della Chiesa. Si tratta di sacerdoti forniti di formazione accademica totalmente dediti alla loro comunità, buoni pastori, che assistono i malati e i moribondi al loro capezzale, e si sentono responsabili della salvezza di tutto il loro gregge e, allo stesso tempo, cercano di vivere un ideale che ai cristiani normali in realtà non è possibile e perciò godono di un alto prestigio tra il popolo cattolico di Dio.
Si tratta pertanto di un ideale che, da un lato, suscita riverenza tra i fedeli cattolici, ma che, dall’altro, è anche fragile. Un ideale difficile da vivere, e non tutti vi riescono e nel quale è possibile anche il fallimento.
– Lei ha sottolineato che la società nel 19° secolo era già diventata critica nei confronti della Chiesa. Allo stesso tempo, molte cattedrali famose e anche ordini religiosi di successo sorsero in quel periodo. Come si accordano questi due aspetti?
Sono due realtà che non si escludono necessariamente tra loro. Da un lato, si può dire che, fin dai tempi dell’Illuminismo e poi nel 19° secolo, il liberalismo si diffuse in quasi tutte le società cattoliche, come anche nell’area protestante. Le correnti critiche nei confronti della Chiesa determinarono un calo dell’influenza della Chiesa. La parola chiave divenne anticlericalismo…
Ma, allo stesso tempo, avviene una specie di automodernizzazione e un rinnovamento della Chiesa. Vengono fondati nuovi istituti religiosi e costruite nuove chiese. Anche la burocrazia non è un fenomeno del tutto negativo, perché riesce a raggiungere il popolo di Dio in un modo intensivo, così che, se, da un lato, una parte della società è persa per la Chiesa, dall’altro, la società è fortemente motivata e percepita come Chiesa popolare, come mai era stato in precedenza.
Pertanto, si verifica in certo senso anche un rafforzamento del cristianesimo. Sono fenomeni che, in certa misura, si condizionano a vicenda. Proprio perché si desidera prendere le distanze dalla miscredenza e dalle correnti critiche nei confronti della Chiesa nelle grandi città, è necessario immunizzare i fedeli, equipaggiarli, approfondire la loro fede, organizzarli in circoli, formarli attraverso la stampa ecclesiastica e via dicendo. Tutto questo è connesso e reciprocamente dipendente.
– Oggi molti preti parlano di sovraccarico di impegni, nel senso che molti considerano amministrativamente loro compiti cose che non hanno nulla a che fare con la pastorale o la liturgia. Questo fenomeno si era già profilato allora?
Si è rivelato poco alla volta per il fatto che la burocrazia aumentò a partire dall’Illuminismo e anche nel 19° secolo. Questo fece semplicemente parte della “professionalità” del ministero parrocchiale. Come la burocrazia nello Stato crebbe sempre più, così avvenne anche nella Chiesa.
Ma naturalmente era qualcosa di diverso, perché le parrocchie nel 19° secolo erano in genere molto più piccole di oggi, dove esistono grandi associazioni. Si tratta di una dimensione del tutto diversa, che oggi ricade sui preti per il fatto che c’è scarsità di clero.
– Oggi in certi ambienti si sostiene che i doveri sacerdotali come l’obbedienza e il celibato non debbano essere presi tanto sul serio. La realtà – dicono – è diversa da ciò che sta scritto. Questo fatto si era manifestato anche prima o si tratta di uno sviluppo nuovo?
Il 19° secolo è in realtà l’epoca in cui soprattutto i parroci divennero molto più dipendenti dal vescovo. Il vescovo, in quel tempo, controlla molto più da vicino la formazione dei preti. Mentre nei secoli precedenti la maggior parte del tempo della formazione in seminario avveniva sotto il controllo dei vescovi, ora è possibile trascorrere l’intero periodo degli studi – spesso anche prima del ginnasio – in un pensionato.
Prima del 19° secolo, i parroci nelle loro parrocchie vivevano in località in genere lontane dal vescovo ed erano più che mai indipendenti. Ci poteva essere forse una visita del vescovo o qualche altro incontro. Uno veniva ordinato dal vescovo ed era quella la prima ed ultima occasione di incontrarlo. Nel 19° secolo nascono i grandi organismi come i vicariati generali.
I vescovi attualmente hanno possibilità del tutto diverse attraverso le disposizioni, gli esercizi per i sacerdoti, la formazione permanente ecc., per rendere i sacerdoti e anche i parroci sempre meno indipendenti. Tutto ciò in certa misura è contenuto anche nel diritto canonico. Avviene che i parroci possono essere più facilmente trasferiti da parte del vescovo e che la gente consideri un dovere di obbedienza da parte del parroco lasciare di nuovo la parrocchia dopo qualche anno.
– Che ruolo esercita il tema dell’abuso sessuale? Lo si può spiegare anche con questi sviluppi?
Questa è una domanda molto difficile perché mancano le fonti per il periodo anteriore al 1945 o sono di difficile accesso in seguito al segreto confessionale. Ma si può ritenere che alcune decisioni abbiano un loro ruolo a questo riguardo. Sviluppi che riguardano l’ideale pastorale.
Anzitutto ci sono impegni del tutto positivi per il fatto che il sacerdote, il cappellano in genere, abbiano il compito di curare la formazione dei giovani e vivano alcuni periodi con loro. Sono cose che forse nessun prete faceva in questa forma nell’epoca pre-moderna. Si tratta di fattori strutturali che possono rendere possibili in certa misura queste cose (gli abusi).
– Lei che cosa si aspetta una grande conferenza che in Vaticano tratterà della figura moderna del prete? Con quale sguardo la osserverà?
Credo che questo dibattito sia andato avanti molto intensamente qui da noi per anni e, di recente, anche in molte altre società, in particolare nell’Europa occidentale e centrale. Sono abbastanza sicuro che non sia un problema europeo o americano, ma che esistano fenomeni del genere anche in altre culture e società in cui questi dibattiti non avvengono così intensamente, sia nell’Europa meridionale che in quella orientale sia nell’ambito extraeuropeo.
Quando se ne parlerà a Roma, è importante che vi sia una sensibilizzazione generale di questo grave problema nella Chiesa. Roma può avere un certo effetto di segnale e rafforzare in certa misura gli standard in tutto il mondo. L’attenzione cresce. Questa comunque è la mia speranza (KNA, 11 febbraio 2022).
[1] Il prof. dott. Klaus Unterburger è docente di Storia della Chiesa medievale e moderna presso la Facoltà di teologia cattolica dell’Università di Regensburg (Ratisbona).
Rendili testimoni
Signore Gesù Cristo,
custodisci questi giovani nel tuo amore.
Fa’ che odano la tua voce
e credano a ciò che tu dici,
poiché tu solo hai parole di vita eterna.
Insegna loro come professare la propria fede,
come donare il proprio amore,
come comunicare la propria speranza agli altri.
Rendili testimoni convincenti del tuo Vangelo,
in un mondo che ha tanto bisogno
della tua grazia che salva.
Fa’ di loro il nuovo popolo delle Beatitudini,
perché siano sale della terra e luce del mondo
all’inizio del terzo millennio cristiano.
Maria, Madre della Chiesa, proteggi e guida
questi giovani uomini e giovani donne
del ventunesimo secolo.
Tienili tutti stretti al tuo materno cuore. Amen.
(Preghiera del Papa Giovanni Paolo II, al termine della Giornata della Gioventù di Toronto).
Le beatitudini e la felicità
Le beatitudini indicano il cammino della felicità. E, tuttavia, il loro messaggio suscita spesso perplessità. Gli Atti degli apostoli (20,35) riferiscono una frase di Gesù che non si trova nei vangeli. Agli anziani di Efeso Paolo raccomanda di «ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”». Da ciò si deve concludere che l’abnegazione sarebbe il segreto della felicità? Quando Gesù evoca “la felicità del dare”, parla in base a ciò che lui stesso fa. È proprio questa gioia – questa felicità sentita con esultanza – che Cristo offre di sperimentare a quelli che lo seguono. Il segreto della felicità dell’uomo sta dunque nel prender parte alla gioia di Dio. È associandosi alla sua ‘misericordia’, dando senza nulla aspettarsi in cambio, dimenticando se stessi, fino a perdersi, che si viene associali alla ‘gioia del cielo’. L’uomo non ‘trova se stesso’ se non perdendosi ‘per causa di Cristo’. Questo dono senza ritorno è la chiave di tutte le beatitudini. Cristo le vive in pienezza per consentirci di viverle a nostra volta e di ricevere da esse la felicità.
Resta tuttavia il fatto, per chi ascolta queste beatitudini, che deve fare i conti con una esitazione: quale felicità reale, concreta, tangibile viene offerta? Già gli apostoli chiedevano a Gesù: « E noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che ricompensa avremo?» (Mt 19,27). Il regno dei cieli, la terra promessa, la consolazione, la pienezza della giustizia, la misericordia, vedere Dio, essere figli di Dio. In tutti questi doni promessi, e che costituiscono la nostra felicità, brilla una luce abbagliante, quella di Cristo risorto, nel quale risusciteremo. Se già fin d’ora, infatti, siamo figli di Dio, ciò che saremo non è stato ancora manifestato. Sappiamo che quando questa manifestazione avverrà, noi saremo simili a lui «perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3,2).
(J.-M. LUSTIGER, Siate felici, Genova, 1998, 111-117 passim).
Beatitudini dell’oggi
BEATI quelli che sanno ridere di se stessi:
non finiranno mai di divertirsi.
BEATI quelli che sanno distinguere
un ciottolo da una montagna:
eviteranno tanti fastidi.
BEATI quelli che sanno ascoltare e tacere:
impareranno molte cose nuove.
BEATI quelli che sono attenti
alle richieste degli altri:
saranno dispensatori di gioia.
BEATI sarete voi se saprete
guardare con attenzione le cose piccole
e serenamente quelle importanti:
andrete lontano nella vita.
BEATI voi se saprete apprezzare un sorriso
e dimenticare uno sgarbo:
il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.
BEATI voi se saprete interpretare
con benevolenza gli atteggiamenti degli altri
anche contro le apparenze:
sarete giudicati ingenui,
ma questo è il prezzo dell’amore.
BEATI quelli che pensano prima di agire
e che pregano prima di pensare:
eviteranno certe stupidaggini.
BEATI soprattutto voi che sapete riconoscere
il Signore in tutti coloro che incontrate:
avete trovato la vera luce e la vera pace.